JACQUES TATI, IL CINEMA È COME UN CIRCO
Il Buster Keaton del cinema francese, e anche un po’ il Max Linder, il Mack Sennett e perfino il Chaplin. «Monsiewr Hulot», insomma, uno degli autori-attori più personali e vividi del cinema europeo fra i 1950 e il 1970. Il suo ultimo film da regista è Il circo di Tati (1974), ambientato interamente in un circo.
Il circo di Tati, dunque.
«Non è un film. Non l’ho né costruito né realizzato come un film. Diciamo invece che è un invito agli spettatori a venire a divertirsi per un’ora e mezza. E se l’ho ambientato in un circo è stato perché ho pensato che fosse la cornice più adatta per consentire agli spettatori di mescolarsi agli attori. È anche per questo che ho chiesto a quanti vi hanno partecipato di venir vestiti come volevano; soprattutto i giovani, dato che il loro modo di vestirsi oggi fa parte del loro modo di esprimersi. E se ho fatto disegnare e montare le scenografie davanti al pubblico è stato per permettere agli scenografi di partecipare anch’essi alla creazione collettiva dello spettacolo. Questa mescolanza fra spettatori, pittori, clown e acrobati finisce per non far più capire chi sia macchinista, operaio o saltimbanco e induce il pubblico ad una partecipazione che tutti pretendono da lui ma che pochi sanno far andare d’accordo con i tipi di spettacolo che gli propongono. Se personalmente ho rifatto il verso a certi atteggiamenti degli sportivi – la sicumera dei campioni, gli impacci dei principianti – è stato proprio per ricreare il clima degli stadi, dando modo al pubblico di fare il tifo sia a favore sia contro con le stesse urla che gli strappano le partite di calcio».
E tutto questo a quale scopo?
«Per far recitare sia quelli che stavano “dentro” allo spettacolo, sia quelli che stanno fuori, nei cinematografi. Nella speranza di riuscire a far finalmente cadere le barriere che da sempre esistono fra lo schermo e gli spettatori. E se alla fine dello spettacolo ho fatto scendere in pista due bambini non è stato per fare tanto “film per ragazzi”, ma per dare agli spettatori di domani la possibilità di reagire contro quella sistematica distruzione dello spettacolo (vero) che oggi si pratica un po’ dappertutto. Ho cercato insomma di ridare alla gente la gioia di vedere, la gioia di ridere, la gioia di partecipare. In una parola: la gioia di vivere ».
Una sua definizione della comicità?
«È il massimo della logica. Una gag i più delle volte è una situazione condotta fino alle sue più logiche ed estreme conseguenze. Il riso nasce quasi sempre da una verità, che si prolunga poi nell’assurdo. Certe cose, ad esempio, che non sarebbero affatto comiche, lo diventano se ci si va a fondo; fino a scorticarle».
E una definizione dell’attore comico?
«È più difficile. Una gag è più semplice pensarla, scriverla, che non recitarla. Ne ho avuto una prova molti anni fa a Londra, dove ero andato per proporre uno spettacolo. Un’audizione di fronte a tre gravi personaggi, rigidi come se avessero ingoiato il classico ombrello. Mezz’ora di virtuosismi, di trovate, sdoppiamenti, moltiplicandomi. Niente, neanche un mezzo sorriso. Fuori, però, in strada, mi resi conto del perché. Vedendo gli inglesi che “vivevano”: i muratori che si passavano i mattoni, il ciclista che distribuiva i giornali nelle edicole, il negoziante che vendeva
frutta dietro al suo banco: quei gesti, quella disinvoltura, quella scioltezza… ogni movimento, ogni espressione rivelava tutto di tutti, facce, caratteri, virtù, vizi. Dei mimi, dei mimi meravigliosi!
Ecco, l’attore comico deve saper essere questo: un mimo che rivela tutto, di se stesso, del personaggio, e anche di quello che l’autore si è dimenticato di dirgli del personaggio. E deve esser nato e cresciuto a contatto con il pubblico: nel music hall, nel circo equestre. Adeguando i propri mezzi, i propri gesti alle reazioni del pubblico, al clamore delle sue risate, al gelo dei suoi silenzi. Se non fa così, niente comicità; o comicità da manuali; fredda, scolastica. Ancora una cosa. L’attore comico deve essere anche uno sportivo. Deve saper correre, saltare, nuotare, andare a cavallo, tuffarsi. Anche tuffarsi. Se Charlot non avesse saputo tuffarsi non gli sarebbe mai riuscita quella pagina stupenda in Tempi moderni (1936), quella sua capriola in due dita d’acqua… ».
Il suo parere su Chaplin?
«Il più grande di tutti. Dicono che sia un orso, ma se tutti gli orsi sono come lui vado subito al Polo».
Il suo film, prima de Il circo di Tati è del 1970; il precedente, Playtime-Tempo di divertimento, risaliva al 1967. Perché tanto tempo fra un film e l’altro?
«Non sono un fornaio. Non posso sfornare film come panini. Non è che me ne stia con le mani in mano, anzi; lavoro, lavoro, tutto il giorno e tutti i santi giorni; ma mi ci vuol tempo: per pensare, per scrivere, per girare. Altra cosa, non posso fare un film se non mi piace, se non ci credo. Posso fare solo le cose che sento; e quando le sento. La TV americana mi aveva offerto somme enormi per fare tutte le settimane un filmetto comico di dieci minuti. Mai. Non so lavorare a comando né a data fissa. Neanche se mi pagano a peso d’oro».
Perché fa cinema?
«Perché mi offre la possibilità di spalancare una terrazza sulla vita e di far vedere alla gente tutte le ricchezze che ci sono; e tutte le bellezze. Soprattutto oggi che tutto sembra così povero e brutto».
Pubblicazioni di riferimento: Positif (AA. e Nrr. VV.), Image et son (AA. e Nrr. VV.), Chaiers du cinéma (AA. e Nrr. VV.), Cinématographe (AA. e Nrr. VV.), 7 domande a 49 registi di Gian Luigi Rondi (SEI Ed.)
GALLERIA FOTO
GALLERIA VIDEO





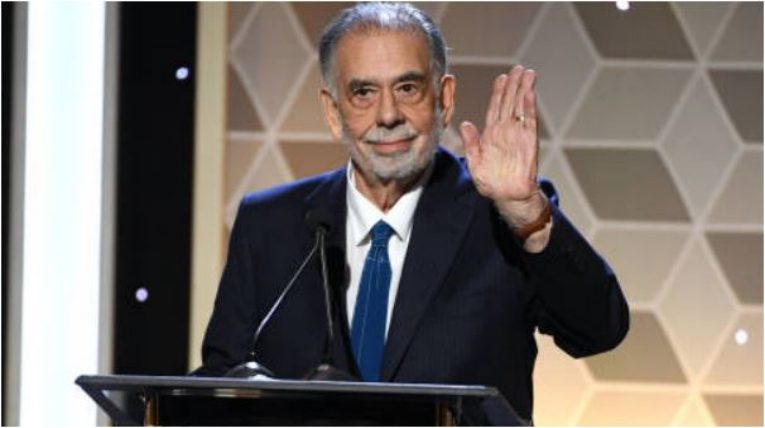

Comments are closed.