JEAN RENOIR, PARTE I: IL NEOREALISMO LIMBICO E LA GRANDE ILLUSIONE
« Le plus grand cinéaste au monde », come lo definisce François Truffaut. Un’esplorazione suddivisa in tre parti sull’opera cinematografica più celebre di Jean Renoir, il suo cinema, la società, l’arte, la politica.
Vogliamo cominciare da lontano, dai primi anni del sonoro da Toni, che risale al ’34?
« Toni è un film che ho girato con amore; l’ho girato con amore perché corrispondeva a certe mie preoccupazioni molto acute. Corrispondeva al periodo della mia vita in cui ero convinto che il cinematografo dovesse essere il riflesso della vita quotidiana. Ero convinto che tutto quello che era composito non fosse adatto al cinematografo e che, in realtà, bisognasse fare dei film come si fa una fotografia: prendendola al volo; come fa Cartier-Bresson con le sue fotografie, cogliendo il soggetto quasi di sorpresa. La possibilità di attuare un tentativo di questo genere me l’offriva il soggetto. E il soggetto l’avevo saputo da un mio amico commissario di polizia nella città di Martigues, Jacques Mortier. Un giorno, mi aveva raccontato una storia, la storia di un delitto commesso nei dintorni di Martigues, appunto; quel delitto, secondo me, aveva un aspetto quasi romantico, un aspetto, anzi, addirittura passionale, così pensai che, se avessi raccontato quella storia con molta sobrietà e senza immaginare cose troppo inverosimili, sarei riuscito ad avvicinarmi in qualche modo a una specie di romanticismo latino, un romanticismo che a me piace molto. I latini hanno un modo di essere romantici che è molto diverso da quello dei danesi o dei tedeschi; il romanticismo latino esplode al sole, il romanticismo latino forse dipende meno dall’ambiente e forse è anche più profondo, credo che dipenda da tutto quello che c’è ancora di panteistico nel cuore e nella mente di ogni popolo mediterraneo ».
Il fenomeno sociale in Toni, gli operai spagnoli e italiani?
« I fenomeni sociali sono una delle tante cose che mi sembravano e che anche oggi mi sembrano molto appassionanti. Martigues è una piccola città industriale del Mediterraneo, in cui, pensi un po’, si raffina persino il petrolio, insomma, un vero e proprio porto petrolifero; fin da quell’epoca – eravamo nel ’34 – cominciava ad avere la sua importanza; a Martigues c’erano degli operai che venivano più o meno da tutto il bacino mediterraneo; non c’erano ancora molti arabi, ma c’erano molti spagnoli, dei portoghesi, degli italiani. L’eroe della mia storia, Toni, dovrebbe essere un italiano. La parte è interpretata da un francese, ma da un francese che viveva al sud, che parlava anche italiano e che aveva potuto osservare da vicino le abitudini dei suoi amici italiani. Per interpretare la parte di Toni, mi rivolsi a un mio amico, che si chiamava Charles Blavette, e gli chiesi di collaborare a fondo con me. Avevo paura degli attori troppo conosciuti: va anche detto che non avrei avuto denaro sufficiente per pagare degli attori celebri. Ma anche avendolo, non li avrei voluti. Avevo troppo paura di quello che succede con gli attori molto conosciuti: non hanno mai il coraggio di cambiare il loro personaggio, vivono e accumulano denaro unicamente vendendo al pubblico solo e sempre la stessa espressione; invece quello che è divertente è di cambiarla, quell’espressione; ma loro sono un po’ come le anatre; sa, le anatre, con quelle piume oleose che ci si può rovesciare addosso dei secchi pieni di acqua senza mai bagnarle. Così realizzai Toni sul luogo, in ambienti autentici, con una maggioranza di attori presi sul posto, o lì vicino, tutto sommato penso che fosse un primo tentativo di quello che più tardi si sarebbe chiamato il neorealismo. Io però non avevo la pretesa di fare nessun tentativo, volevo semplicemente raccontare una storia che mi aveva colpito e la volevo raccontare nel modo più diretto, dando cioè alla narrazione la precedenza sulle qualità tecniche. Anche se, dal punto di vista delle qualità tecniche, Toni non lascia certo a desiderare. Registrai il sonoro tutto dal vero, non c’è doppiaggio – detesto i doppiaggi, dato che ci siamo tengo a dichiararlo – e Toni così fu girato esattamente nelle condizioni che desideravo. Fu prodotto da uno dei miei migliori amici, vale a dire da Pierre Gaut; lui volle farsi aiutare da Marcel Pagnol, che ci dette non solo il suo laboratorio ma anche i suoi consigli che, come lei può immaginare, erano ottimi. Le riprese durarono parecchio, perché lavoravamo in esterni e come lei sa è sempre abbastanza difficile lavorare in esterni; la televisione ce lo dimostra… E fine abbiamo ultimato Toni, un film che amavo molto, che proprio mi piaceva; lo presentai al pubblico convinto che sarebbe stato un successo; invece, purtroppo, non l0 fu per niente ».
Le canzoni, in questo film?
« Sì. Toni, fra le tante gioie, mi ha procurato quella di ricordarmi le canzoni che avevo sentito spesso da piccolo, da bambino. Nel villaggio di Cagnes, dove mio padre aveva una proprietà e dove sono cresciuto, c’erano molti lavoratori piemontesi, e questi lavoratori piemontesi cantavano i canti delle loro montagne che erano stupendi; erano dei canti che si cantano a piena gola, forzando la voce al massimo, magari a volte in tono di falsetto… Proprio belli. Così mentre giravo Toni, trovai dei boscaioli piemontesi che lavoravano nei dintorni di Martigues e chiesi loro di cantarmi le loro canzoni durante la scena di un matrimonio. Sì… sono proprio dei canti commoventi… Ci sono anche dei carbonai corsi che cantano delle canzoni per lingua e qualità molto vicine a quelle italiane ».
Adesso poniamo un focus su un altro film, Il delitto del signor Lange, che girò l’anno dopo.
« Un film diametralmente opposto a Toni; corrisponde a un periodo della mia vita in cui avevo un’ammirazione senza limiti per l’attore. Ne Il delitto del signor Lange ho cercato di presentare un attore in libertà, un po’ come si potrebbe presentare un animale pieno di seduzione, un animale… un animale curioso e interessante… intendo dire Jules Berry. Jules Berry… beh, è semplice: Il delitto del signor Lange è Jules Berry. René Lefèvre è magnifico, Florelle è splendida, Nadia Sibirskaïa è straordinaria, Maurice Baquet è stupendo, ma secondo me il film non esisterebbe senza Jules Berry. Jules Berry vi ha riversato tutta la sua fantasia, la sua capacità di improvvisazione, la sua libertà di azione… Non riusciva a imparare niente a memoria e così Jacques Prévert ed io facevamo le prove prima, poi improvvisavamo delle modifiche ispirate ai cambiamenti fatti da Jules Berry, perché il vero testo di Prévert, lui, era incapace di impararlo così com’era. Per noi, comunque, andava benissimo anche così; aveva un tale senso della situazione e del suo personaggio che le parole che inventava al posto di quelle scritte da Prévert e da me erano belle, e forse anche più belle delle nostre ».
L’influenza del Fronte Popolare in questo film?
« Qui è grandissima! Perché il film corrisponde a un’epoca in cui avevamo tutti una gran paura di Hitler; eravamo dei sostenitori entusiasti di tutto quello che era all’opposto di Hitler. In Francia, il Fronte Popolare ha dato il via a parecchi tentativi di questo genere, concorrendo a creare uno spirito di fraternità., di solidale amicizia, di cordialità anche un po’ scherzosa che erano preziose, anzi, essenziali, per fare dei film ».
Il realismo, Parigi e Émile Zola?
« È una scoperta che io feci quasi contemporaneamente al “sonoro”, che il patrimonio francese, cioè, era d’una ricchezza infinita, e che avevo torto di voler girare dei film ambientati in Paesi esotici o ambientati in epoche più romantiche, mentre avevo sotto i miei occhi, a Parigi, lo spettacolo della strada, lo spettacolo di tutti i giorni, che è di una immensa ricchezza. Io ho imparato di più osservando una donna che puliva il cortile, o delle lavandaie che lavavano la biancheria, o un imbianchino sulle impalcature… ho appreso di più per il mio mestiere, per il cinema, che non leggendo dei libri… La mia ammirazione per Zola è senza limiti… Parigi, mi ha aiutato più di qualsiasi altra cosa… è stata l’osservazione di Parigi che mi ha aiutato; molto più della lettura di qualsiasi libro ».
Jacques Becker, suo assistente, e il “gruppo”.
« Beh, sì, quella era l’epoca in cui si lavorava sempre in gruppo, in un film dopo l’altro, amici, uniti, quasi fratelli. Con Becker, però, era diverso. Becker fu mio assistente per dieci o dodici anni, mui mi considerava suo padre e io lo consideravo mio figlio. Quando giravamo certi film, La grande illusione (1937), per esempio, prendevamo una camera in albergo e l’abitavamo spesso insieme; abitavamo insieme perché nel cuore della notte uno di noi due si svegliava e diceva: “Ah! e se facessimo così? O se invece facessimo in quest’altro modo?”. C’era una intimità. assoluta. Quando gli nacque una figlia, fui io a dirgli di chiamarla Sophie, perché Sophie sarebbe presto diventato un nome alla moda. Non mi sono sbagliato; Sophie oggi è un nome alla moda… ».
Un film che fa la data nella sua carriera è La grande illusione, appunto.
« La grande illusione corrispondeva allora – e corrisponde anche adesso – a parecchie preoccupazioni: preoccupazioni sul piano generale, dal punto di vista politico, e preoccupazioni sul piano artistico e tecnico. Dal punto di vista artistico e tecnico, mi sembrava di avere raggiunto una conoscenza abbastanza ampia del mio mestiere per poter tentare di rappresentare la realtà – il clima, il senso realistico, cioè – e di poter affidare tale rappresentazione della realtà ad uno stile rigoroso. Volevo tentare di presentare dei personaggi veri, vestiti con i veri abiti del loro mestiere e della loro posizione sociale, truccati come lo sarebbero stati nella vita – o meglio come non lo sarebbero stati nella vita – insomma, con tutte le caratteristiche della gente che si incontra per la strada, ma li volevo presentare anche con un certo stile, con un certo ritmo… e soprattutto, diciamolo pure, con una certa nobiltà. I.a mia idea base, in questo film, era la convinzione che la nobiltà appartiene a quasi tutti gli individui di questo mondo. Basta saperla cercare, basta scoprirla, basta evocarla. Con un po’ di pazienza, la nobiltà verrà fuori per forza, e si manifesterà, prima o poi. Dal punto di vista della situazione generale – glielo posso spiegare in poche parole – quello che mi preoccupava era, ancora una volta, Hitler. Sentivamo che una guerra sarebbe presto scoppiata e i ricordi di quella precedente, cui avevo preso parte, non finivano di ossessionarmi. C’è ancora un’altra cosa che mi ha indotto a realizzate La grande illusione, ed è il mio odio per i racconti di guerra. Al cinema, in letteratura, in tutti i campi i racconti di guerra sono sempre pieni di falso eroismo. Le guerre hanno i loro residuati e tra questi residuati c’è l’uso letterario che si fa delle guerre. Improvvisamente, gli eroi di guerra si trasformano in eroi del tutto irreali, imbottiti di frasi retoriche. I miei ricordi di guerra, invece, erano diversi. Così io volevo mettere l’accento sulla semplicità di quelli che fanno la guerra. Ecco, questa è una delle cose che ho voluto ne La grande illusione. Per questo mi sono preoccupato soprattutto del ritratto dell’ufficiale di cavalleria, interpretato da Pierre Fresnay. In tutti i Paesi del mondo la cavalleria è rimasta un’arma un po’ particolare; nel senso che ha conservato delle tradizioni, diciamolo pure, abbastanza singolari… Io volevo ritrarre un uomo imbevuto di queste tradizioni, ma allo stesso tempo preso nell’ingranaggio della vita quotidiana e nei bisogni di tutti i giorni. È stato un grande piacere per me girare La grande illusione, anche perché mi ha dato la rara possibilità di diventare molto amico di un uomo che ammiravo moltissimo Erich von Stroheim. Era stato uno dei registi del cinema che mi avevano spinto a fare il cinema. Non direttamente, perché non lo conoscevo; ma la visione, da giovane, dei suoi film più importanti era stata uno dei motivi che mi avevano indotto a fare dei film. Non le parlerò di Jean Gabin, lei sa chi è: è il cinema fatto persona. Quell’uomo basta solo che appaia su uno schermo e che dica qualsiasi cosa e tutto diventa di colpo interessante. Con lui è persino troppo facile fare dei film. Poi c’era Marcel Dalio, e c’era il bravo Julien Carrette, un autentico Pierrot, esattamente come il Gilles di Antoine Watteau: un personaggio del Settecento sperdutosi nella nostra epoca ».
Il tema sociale del film…
« Il tema sociale è l’esame di quella situazione che si è soliti definire la casta. Io sostengo che le caste esistono. Io sostengo che gli uomini, la gente, si raggruppano, per religioni, per lingue, per gusti comuni; nel sistema delle caste si raggruppavano spontaneamente per nascita; ma anche oggi ci si raggruppa per nascita. Le caste non sono scomparse. E La grande illusione tende proprio a illustrare le differenze che esistono fra un meccanico, Gabin, un aristocratico, Fresnay, un ricco banchiere ebreo, Dalio, e un piccolo attore da niente, Carette. E anche tutti gli altri – le sarà facile osservarlo – non si raggruppano per gradi o per nazionalità, ma per caste ».
Pubblicazioni di riferimento: 7 domande a 49 registi di Gian Luigi Rondi (SEI Ed.) , Cineforum (AA. e Nrr. VV.), Filmcritica (AA. e Nrr. VV.), Positif (AA. e Nrr. VV.), Chaiers du cinéma (AA. e Nrr. VV.), Bianco e nero (AA. e Nrr. VV.).
GALLERIA FOTO
GALLERIA VIDEO




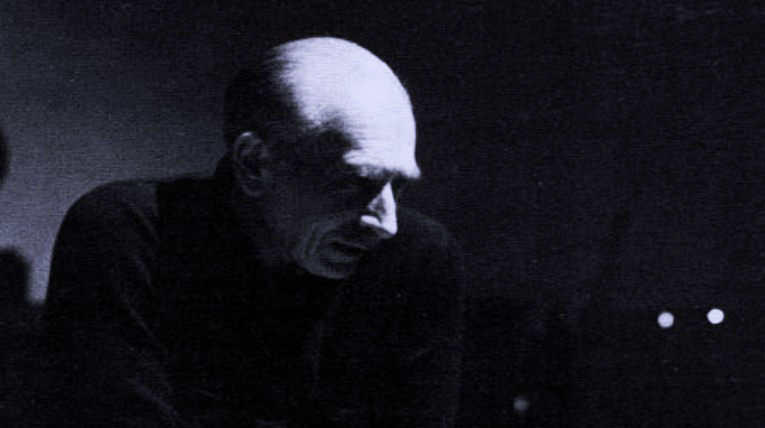


Comments are closed.