ITALIAN GRAFFITI
Viaggiando nel passato, non per nostalgia o vano amarcord, si possono avvertire meglio i fremiti dell’infinito futuro che ci sta davanti. E dai protagonisti del nostro cinema del dopoguerra è venuta una lezione straordinaria di lettura, interpretazione e rappresentazione degli italiani. Ma non sempre: forse il difetto capitale del cinema nazionale nell’ultimo ventennio è stato quello di perdere ll contatto con la realtà sociale e culturale del Paese.
Le prime immagini che mi vengono in mente sono cose mai (da me) viste, ricordi tramandati da libri avventurosi. Così, dovendo scegliere un simbolo del cinema italiano “rifondato” nel secondo dopoguerra, penso a Roberto Rossellini che gira per la grande città, ancora senza pellicola, ma con le tasche piene di monetine e gettoni, attaccato al telefono per cercare improbabili finanziatori (o nobildonne finanziatrici, magari da convincere con uno dei suoi sguardi da seduttore intelligente). I tempi erano assai difficili, anche dopo che gli occupatori nazisti se n’erano andati verso il nord, e dunque all’inizio il progetto era semplice, non troppo ambizioso: fare una sorta di “corto”, un documentario su Don Morosini, prete coraggioso fucilato dai tedeschi. Il primo copione 1’aveva scritto Alberto Consiglio, poi erano subentrati per la sceneggiatura definitiva, accanto a Rossellini medesimo, Sergio Amidei e un po’ più tardi un giovanottino magro, amante delle caricature e del teatro di varietà. Il ragazzo, che si chiamava Federico Fellini, forse era stato invitato per la sua amicizia con un mattatore da teatro leggero, Aldo Fabrizi, che sembrava al regista il volto ideale per la parte tragica del sacerdote buono. L’idea, dato che si trattava di un attore di repertorio comico, era folgorante. Ma Fabrizi non era un tipo che si convinceva facilmente e inoltre voleva vedere il colore dei soldi, prima di cominciare il lavoro. Potrei continuare per un pezzo a narrare l’avventurosa nascita di Roma città aperta, dalla lenta strategia con cui Fellini convinse il riluttante Fabrizi a dire di sì, alla folle corsa di Anna Magnani, furente di gelosia verso Massimo Serato, fedifrago amante in fuga («A’ frocio, a’ fio de ‘na mignotta» e via ingiuriando), una scenata avvenuta sul set sotto gli occhi del regista, il quale secondo le leggende avrebbe esclamato al volo: «Fermi tutti, ho trovato, ecco come morirà Nannarella». Nacque così una delle scene madri della storia del cinema con la coraggiosa popolana Pina (la Magnani, ovviamente) falciata con una raffica dalla camionetta nazista. Sono storie narrate con diverse sfumature dai protagonisti dell’epoca, memorie che hanno costituito anche il materiale per un bel romanzo di Ugo Pirro (Celluloide), poi trasformato in un film da Carlo Lizzani. State attenti, non si tratta di aneddoti folkloristici, ma uno dei modi possibili per spiegare le radici del neorealismo (come dire il miglior momento del cinema italiano), che non fu una corrente poetica in senso stretto ma piuttosto uno stato di necessità, un comune vedere e sentire che unì autori (i maggiori e i minori) spesso assai distanti fra di loro.
Lo spiegò bene una volta col suo tono disincantato Vittorio De Sica: «Non è che un giorno ci siamo seduti a un tavolino di via Veneto, Rossellini, Visconti, io e gli altri e ci siamo detti “adesso facciamo il neorealismo”. Senza bisogno di premesse teoriche i maestri del dopoguerra si trovarono a partecipare, seguendo ognuno la sua prospettiva, alla costruzione del nuovo cinema italiano. Alle spalle avevano tutti il lungo viaggio dentro il fascismo. Luchino Visconti con la sua cultura di nobile giramondo (era stato in Francia a imparare il mestiere da Renoir) e l’ostentato impegno politico (nella Roma occupata fu imprigionato dai nazisti e si salvò solo grazie a tribolate vicende); Rossellini da tecnico dello sguardo, affascinato dal reale e ostile alla calligrafia da studio, anche quando girava film moderatamente dalla parte del Duce (La nave bianca, Un pilota ritorna, L’uomo della croce); De Sica addirittura da attore brillante, mascalzone ideale per il pubblico del decennio Trenta, dolce seduttore. Maturati dagli eventi, nel decennio Quaranta questi tre autori, che diventarono i simboli del nostro cinema nel mondo (con un’eredità ripresa più tardi in tempi e luoghi lontani, dalla Francia della nouvelle vague all’America di Martin Scorsese), compirono percorsi autonomi: Visconti inseguendo la via del romanzo, dal noir americano a Giovanni Verga, da Tomasi di Lampedusa a Thomas Mann; Rossellini continuando a guardare ciò che accadeva intorno a lui e compiendo viaggi sconvolgenti, dalle ansie di guerra e di pace di un’Italia resistente smarrita, alle macerie della Germania, ripartita dall’anno zero; De Sica tentando insieme all’amico Cesare Zavattini una sintesi poetica, a tratti buffa, fra la tragedia della realtà quotidiana e la speranza utopistica di una fuga verso la felicità su un cavallo bianco (Sciuscià) o su una scopa volante (Miracolo a Milano). Dietro la sacra trinità c’era tutta una cinematografia in movimento: De Santis con le sue mondine da “riso amaro”; Luigi Zampa, aspro cantore della pavidità umana, in anni “facili e difficili”; Carlo Lizzani bravo nel leggere Pratolini (Cronache di poveri amanti) e la Storia patria (Il processo di Verona) e via via gli altri sino alle prime, sorprendenti opere di Antonioni e Fellini. Rientrano nell’atmosfera, con toni incalzanti da romanzo d’appendice, i drammoni di Raffaello Matarazzo, le ragazze in rosa da”piazza di Spagna” o da “terza liceo” narrate da Luciano Emmer, compagne e sorelle maggiori dei “poveri ma belli” poi inventati da Dino Risi, l’Italia rusticana e dolcemente inesistente di Due soldi di speranza (Castellani) o della saga di Pane, amore e fantasia (immaginata da Luigi Comencini, con De Sica ironico maresciallo e Gina Lollobrigida bersagliera contro Sofia Loren in una sflda indiretta). Persino i comici, da Totò a Macario, a modo loro, facevano parte del gruppo: narravano, scherzando, come avevamo perso la guerra; cercavano una casa stabile e almeno un pranzo (al giorno) sicuro. Viene anzi la tentazione di usare una frase del principe De Curtis sulle radici della sua arte, per allargarla a tutto il cinema italiano del dopoguerra: «Io so a memoria la miseria, e la miseria è il copione della vera comicità. Non si può far ridere, se non si conoscono bene il dolore, la fame, il freddo, 1’amore senza speranza, la disperazione e la solitudine di certe squallide camerette ammobiliate alla fine di una recita in un teatrucolo di provincia e la vergogna dei pantaloni sfondati, il desiderio di un caffellatte…». Poi le cose cambiarono, cominciò un’altra storia che è quella nostra, delle generazioni senza fame, cresciute, fra benessere (lo chiamarono “il boom”) e contestazione, nella seconda metà del Novecento. Anche il cinema dovette per forza mutare. II regista simbolo della trasformazione è Federico Fellini, che dal neorealismo era partito anche come autore in proprio (sino a I vitelloni) e poi imboccò diversi sentieri, osservando il mondo d’intorno (La dolce vita) o se stesso (Otto e mezzo) con la fantasia di un viaggiatore allucinato o di un ardito illusionista (“il matto”, re del circo da strada) non privo di straziate nostalgie e di terribili incubi.
Altri nomi si potrebbero fare: penso al lavoro sulle immagini di Michelangelo Antonioni, che non fu solo deserto (rosso) e alienazione, ma anche avventura e scoperta di nuovi linguaggi, o al realismo (non più neo) del miglior Francesco Rosi (La sfida, Salvatore Giuliano, Le mani sulla città). Il percorso potrebbe continuare fermandosi su Pasolini e Ferreri, poeti anarchici e sovversivi, su Bernardo Bertolucci e Marco Bellocchio, i ragazzi selvaggi del decennio Sessanta, arrivando sino ai protagonisti del 2002, con Nanni Moretti e Roberto Benigni a guidare un gruppo per niente compatto. Ma altre piste sono percorribili, e fu importante la capacità di usare e reinventare “i generi”, anche quelli apparentemente estranei alla nostra cultura (il western epico di Sergio Leone e compagni; il fanta-poliziesco di Elio Petri; l’horror di Mario Bava e del giovane Argento). Purtroppo a gioco lungo molto è stato schiacciato dall’egemonia della commedia, certo aurea nei suoi modelli alti (Monicelli, Risi, Germi, forse il primo Scola) ma poi diventata maniera e gabbia soffocante, nella sua costante omologazione troppo sentimentale. L’ultima prospettiva significativa (la meno studiata) è la crescita del sistema produttivo (Cinecittà, piccola Hollywood dei sogni autarchici) e la sua progressiva caduta, sino alla crisi (grave) e alla situazione da monopolio (al massimo duopolio) dei tempi più moderni. Certo, comparando le passate stagioni e la presente, viene la tentazione di abbandonarsi allo sconforto. Ma è opportuno non sbilanciarsi in diagnosi apocalittiche e definitive. Infatti proprio sfogliando la collezione de L’Europeo, trovo un durissimo epitaffio pronunciato nel 1966 da Roberto Rossellini in un impetuosa intervista concessa a Lietta Tornabuoni: «Il cinema non c’è, non esiste. Il cinema è finito. Il cinema è un cadavere…». Lo sfogo va inquadrato storicamente: il maestro di Paisà in quel periodo stava sperimentando altri linguaggi (la TV specialmente), con una tensione storico-didattica, che lo portò anche a risultati alti (La presa del potere di Luigi XIV, realizzato proprio nel ’66), ma sostanzialmente sbagliava analisi. Il cinema non era né morto né moribondo; anzi, dalla seconda metà del decennio Sessanta sino agli anni Ottanta si registrò una sorta di splendido rinascimento in America (Scorsese, Coppola, Spielberg, Lucas…) e non mancarono scatti di vitalità nella vecchia Europa, dalla Germania del tempestoso “Film&Drang” (Fassbinder, Herzog, Wenders) alla stessa Italia, in cui i migliori risultati arrivarono da registi arditi, che viaggiarono lontano da casa (il Pontecorvo di Algeria, l’Antonioni inglese e americano, il Bertolucci che volò dalla “sua Parigi” incontro al mondo). Allo stesso modo del furente Rossellini magari noi oggi non sappiamo cogliere e capire (speriamolo) il valore di alcune opere o autori che cresceranno nel corso del tempo. Anche a tale scopo, in fondo, servono album speciali come questo: viaggiando nel passato, non per nostalgia o per un vano amarcord, si possono avvertire meglio i fremiti dell’infinito futuro che ci sta davanti. Il che naturalmente non ci impedisce di formulare giudizi precisi: guardandoci dietro le spalle possiamo azzardare che il difetto capitale del nostro cinema dell’ultimo ventennio è stato quello di perdere il contatto con la realtà, narrata per lo più con gli schemi della commedia, o nei casi migliori (Moretti, Benigni) col filtro di una personalità forte sempre in primo piano.
Le eccezioni più interessanti sono il rigore “religioso” di Ermanno Olmi (Il mestiere delle armi è il film italiano più bello del nuovo secolo) e il realismo lirico di Gianni Amelio, che passa dal Sud depresso all’intuizione della catastrofe d’Albania. E non bisogna scordare che tentare altre vie, rispetto al modello della commedia popolare o borghese, è anche un problema economico. Così Bertolucci (e dopo di lui, con minor fortuna, Tornatore), non avendo più estro e voglia di raccontare l’Italia, sceglie la formula della coproduzione internazionale: la trilogia della lontananza. (con la punta de L’ultimo imperatore) lo porta al trionfo degli Oscar, ma lo rende, quando torna a casa, quasi uno “straniero”, spaesato e di cattivo umore. Eppure non è detto che il viaggio (per Bertolucci e gli altri) finisca qui, che l’assedio non possa essere spezzato. Fatalmente tanti nomi importanti mancano in questa cavalcata introduttiva (e nell’antologia delle testimonianze), perché il mare era vasto, sterminato. E poi, in definitiva, questo è quel che conta per uno spettatore (professionista o no, non fa differenza): seguire le proprie passioni, valutare ciò che resta nella mente e nel cuore, sapendo bene, come notò Italo Calvino, che «il film di cui ci illudevamo di essere solo spettatori è la storia della nostra vita». Nella memoria sono scolpite alcune immagini, che forse non si sono neppure scelte. Personalmente, avendo passato buona parte del mio tempo in una sala buia, ho la testa piena di figure in movimento. Ne butto in campo qualcuna, a occhi chiusi, senza pensare. Io mi ricordo del partigiano agonizzante che mormora: «È andato tutto male da che è morto Lupo» (Paisà); di Totò e 1’onorevole Trombetta (in bocca) nello scompartimento del treno; di Zampanò che piange la morte di Gelsomina davanti al mare nero come un rimorso (La strada); del Principone che balla l’ultimo valzer (Il Gattopardo); e di Clint Eastwood che accende il carillon e, incurante di qualche dollaro in più, sussurra al crudele Volonté, prima del duello fatale: «Indio, il gioco tu lo conosci».
CLAUDIO CARRABBA
GALLERIA FOTO






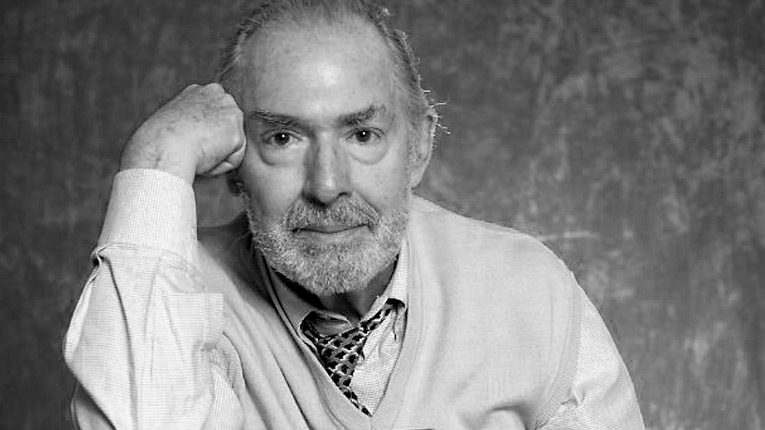
Comments are closed.